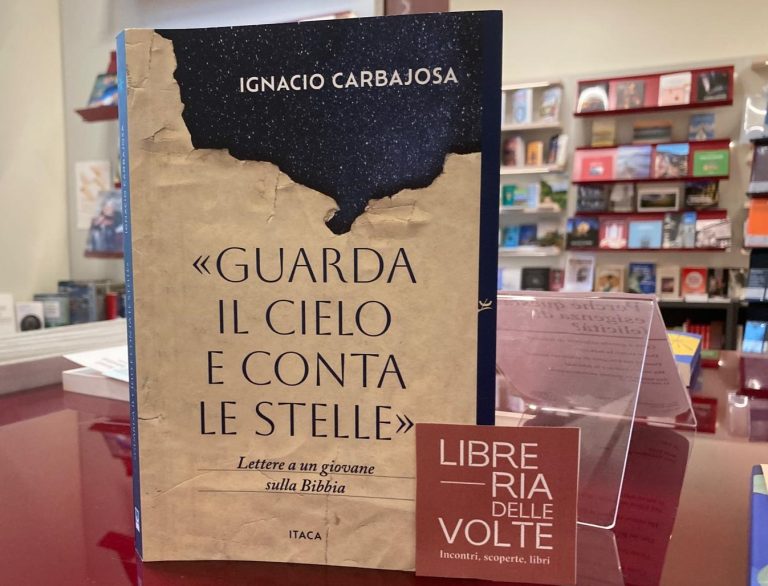NEWMAN DOTTORE DELLA CHIESA/ Obbedire a quella voce
divina che parla dentro di noi
Michiel Peeters Pubblicato 1 Novembre 2025
Oggi papa Leone XIV proclama san John Henry Newman dottore
della Chiesa. Il suo insegnamento sulla coscienza è un punto di non ritorno
Il 28 ottobre, Papa Leone XIV ha dichiarato san John Henry
Newman co-patrono della missione educativa della Chiesa, insieme a san Tommaso
d’Aquino. Oggi, 1° novembre, lo proclamerà Dottore della Chiesa. In questo
articolo discuterò una delle intuizioni più sorprendenti di Newman, ovvero che
la coscienza umana ha in ultima analisi la precedenza sull’autorità
ecclesiastica e che, paradossalmente, negarlo equivale a segare le gambe della
cattedra di Pietro.
Nel presentare il pensiero di Newman, svolgerò un confronto
serrato con quanto ha detto sull’argomento Luigi Giussani, la cui “genialità
pedagogica e teologica” è stata anch’essa riconosciuta dalla Chiesa (Francesco,
Discorso ai membri di Comunione e Liberazione, 15 ottobre 2022).
Mentre la mentalità dominante odierna nelle sue teorie nega
del tutto l’utilità e la necessità dell’autorità (ma poi sant’Ambrogio osserva
giustamente: “Quanti padroni ha chi è fuggito da uno solo?”), ci sono cattolici
che – per pigrizia o per “tenere” le persone – direbbero che l’autorità
ecclesiale prevale sulla coscienza personale, ad esempio con il seguente
ragionamento: finché non si conosce Cristo nella sua Chiesa, vale la coscienza;
ma chi accetta che Cristo è Dio può e deve semplicemente obbedire a Lui e alla
Chiesa. Tuttavia, don Giussani dice: “Guai calcolare su [ignoranza e passività]
per ‘prendere’ o ‘tenere’ la gente! Ogni adesione al cristianesimo, in quanto
ha di puramente meccanico, non possiede valore. Perciò guardiamo con molta
perplessità ogni attaccamento puramente tradizionale e ogni improvvisato
entusiasmo. L’ambiente proprio della libertà è la convinzione, illuminata e
volitiva” (Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, 2006, p. 29).
La tesi difesa da Newman nella sua Lettera al Duca di
Norfolk (1875) – meno di cinque anni dopo il dogma dell’infallibilità papale –
è che ci sono “estremi casi in cui la coscienza possa venire in collisione con
la parola del Papa e che debba esser seguita nonostante quella parola” (Newman,
Lettera al Duca di Norfolk, p. 57). Con il suo famoso aforisma: “Certo se fossi
obbligato a mescere fra brindisi d’un banchetto la religione (cosa non molto
probabile), io berrei, se vi piace, alla salute del Papa, ma prima alla
Coscienza, e poi al Papa” (ibid., 69).
Per comprendere questo, è fondamentale capire che cosa
intende Newman (e la dottrina cattolica) per “coscienza”. Essa è un “elemento
costitutivo della mente, come può essere la nostra percezione delle altre idee,
la nostra facoltà di ragionare, il nostro sentimento dell’Ordine e del Bello, e
le altre nostre doti intellettuali”.
È “un principio, posto in noi prima che avessimo alcun
tirocinio; benché un tal tirocinio e l’esperienza fossero necessari alla forza,
incremento e debita formazione di esso”. Non è una “creazione dell’uomo”, ma
“la Voce di Dio nella natura e nel cuore dell’uomo”. È il “testimone interiore
e dell’esistenza e della legge di Dio” (ibid., 58; cfr. Giussani, Il senso
religioso, 2023, pp. 75-77, 156-160, 167).
È un “principio [che non può] risolversi in una combinazione
di principi naturali più elementari di lui”. È un “dettato [che importa] la
nozione della responsabilità, del dovere, di una minaccia e d’una promessa, con
vivezza tale che lo [distingue] da tutti gli altri elementi costitutivi della
nostra natura” (Newman, Lettera al Duca di Norfolk, p. 59).
È “la messaggera di Colui, che con la Natura e con la Grazia
ci parla dietro un velo, e ci ammaestra e ci regola per mezzo dei suoi
rappresentanti” (ibid., 58). In breve, “la Coscienza è l’aborigene Vicario di
Cristo, profeta nelle sue informazioni, monarca nei suoi perentori decreti,
sacerdote nelle sue benedizioni ed anatemi, e, se mai potesse cessare nella
Chiesa l’eterno sacerdozio, in essa rimarrebbe il principio sacerdotale e
conserverebbe lo scettro” (Newman, ibid., p. 59).
Newman sottolinea poi che nulla di tutto ciò è in linea con
la mentalità dominante attuale. Quest’ultima, infatti, conduce “una lotta
deliberata, quasi direi una cospirazione contro i diritti della Coscienza… Ci
si dice che la coscienza [non è altro che una distorsione nell’] uomo primitivo
ed ignorante; che il suo imperio è una immaginazione” (ibid., p. 59-60).
Oppure, quando il termine viene utilizzato, non è nel suo
significato corretto di “severa ammonitrice”, ma nel senso di quella
“contraffazione” che ne ha usurpato il titolo nel XIX secolo, vale a dire il
diritto di fare di testa propria (ibid., 60-61).
Ma la coscienza nel suo vero senso non è una fantasia o
un’opinione, bensì una “debita obbedienza a quella che vuol essere tenuta qual
voce divina, parlante al nostro spirito” (ibid., p. 64-65). Appartiene “a Dio e
non all’uomo, siccome un Angelo che attraversando la terra, non ne divien
cittadino o dipendente dal Potere Civile” (ibid., p. 58-59; cfr. Giussani, Il
senso religioso, p.11-13).
“Per avere il diritto di opporsi all’autorità suprema … del
Papa, [la Coscienza] dev’essere qualche cosa di meglio di quella infelice
contraffazione…. Se, in un dato caso, deve esser seguita, come sacra e sovrana
maestra, i suoi dettati per prevalere sulla voce del Papa debbono essere la
conseguenza di gravi considerazioni, di preghiere, e di tutt’i mezzi atti a
formare un giusto giudizio della materia di che trattasi…. A meno che un uomo
non si senta sicuro di dire a sé stesso, come dinanzi a Dio, che egli non deve
e non osa di agire secondo le ingiunzioni papali, egli è obbligato ad obbedire
al Papa, e commetterebbe un gran peccato a disobbedirlo” (Newman, Lettera al
Duca di Norfolk, p. 66).
Chiarito questo, Newman sottolinea che, secondo la dottrina
cattolica, abbiamo il “dovere d’obbedire in ogni caso alla nostra coscienza”.
“Colui il quale opera contro coscienza perde la sua anima” (ibid., 67)
“Naturalmente, se egli è colpevole dell’errore, perché avrebbe potuto evitarlo
usando maggior cautela, egli risponderà a Dio; ma tuttavia deve operare secondo
quell’errore, finché vi ci si trova, perché lo crede sinceramente essere la
verità” (ibid., 67-68).
“Così se il Papa ingiunge ai Vescovi Inglesi di ordinare ai
loro preti di agitarsi energicamente in favore del Tetotalismo, ed uno fra essi
fosse convinto che l’astinenza dal vino fosse in pratica un errore Gnostico, e
però sentisse di non poter obbedire senza peccato; ovvero poniamo che il Papa
ordinasse di far lotterie in ciascuna missione per qualche scopo religioso, ed
un prete potesse asserire dinanzi a Dio di credere le lotterie moralmente
cattive, codesto prete, in ognuno dei due casi, commetterebbe hic et nunc un
peccato se obbedisse al Papa, o che avesse ragione o torto nella sua opinione,
e se torto, ancorché egli non avesse avuta sufficiente cura di conoscere la
verità nella materia” (ibid., p. 68; corsivo aggiunto).
Il Dottore della Chiesa sostiene che la Chiesa non si è mai
espressa contro l’autorità della coscienza personale. Se così è sembrato, è
dovuto al fatto che le sue parole sono state estrapolate dal contesto (ibid.,
p. 61-62; cfr. Giussani, Perché la Chiesa, 2014, p. 190-193). “Nessuna beffa di
Papa si trova in alcun formale documento, indirizzato ai fedeli tutti, per
quella dottrina solenne del diritto e dovere di seguire quella divina autorità,
che è la voce della Coscienza, sulla quale invero è fondata la Chiesa stessa”
(Newman, Lettera al Duca di Norfolk, p. 62). Newman approfondisce poi
quest’ultimo punto essenziale: “Davvero se il Papa parlasse contro la
Coscienza, nel proprio significato della parola, egli commetterebbe un
suicidio, smoverebbe il terreno ove poggiano i suoi piedi. Egli ha la missione
di predicare…, proteggere e rafforzare quella luce che illumina ogni uomo che
viene in questo mondo [Gv 1,9]. Sulla legge della coscienza e sulla santità di
essa si fondano tanto la sua autorità in teoria quanto la sua potenza in fatto.
Spetta alla storia dire se questo o quel Papa, in questo mondo triste, tenne
sempre di mira, in tutti i suoi atti, questa grande verità. Io qui considero il
Papato nel suo ufficio e nei suoi doveri… Ci apparirà chiaro che il Papato ha
conquistato il suo posto nel mondo e compiuto tante meraviglie a questo modo
solo, fondandosi sul sentimento universale del giusto e dell’ingiusto…;
principi fondamentali, profondamente impressi nel cuore degli uomini. L’essere
ordinato da Dio a tener alte, proteggere e rafforzare quelle verità, di che il
legislatore ha dotato la nostra natura, è la sola spiegazione d’una lunghezza
di vita più che antidiluviana. La sua ragion d’essere sta nella difesa della
legge morale e della Coscienza. Il fatto della sua missione è la risposta a
coloro che si lamentano dell’insufficienza del lume naturale; e l’insufficienza
di questo lume è la giustificazione della sua missione (Newman, Lettera al Duca
di Norfolk, p. 62-63; corsivo aggiunto).
In quest’ultima frase, Newman fa riferimento alla necessità
della rivelazione, data la difficoltà esistenziale che l’essere umano
sperimenta nel rimanere fedele a se stesso. Secondo Giussani, esistenzialmente,
la ragione umana descrive una parabola: senza l’aiuto divino, non possiamo
mantenere al livello delle nostre intuizioni più elevate, per quanto accurate
(Giussani, Il senso religioso, pp. 189-191, 195-205; cfr. Tommaso d’Aquino,
Summa Theologiae 1.1.1: “La verità che la ragione potrebbe raggiungere su
Dio…”).
Ancora Newman: “La Religione Naturale, ancorché siano certe
le sue fondamenta e dottrine, quando s’indirizzano agli animi riflessivi e
gravi, abbisogna d’essere sostenuta e completata dalla Rivelazione, affine di
parlare con efficacia all’umano genere” (Newman, Lettera al Duca di Norfolk, p.
63).
Tuttavia, mentre la natura può arrivare a qualche punto
anche senza rivelazione, non vale il contrario. “Sebbene la Rivelazione sia …
distinta dalla scienza della natura…, tuttavia non ne è indipendente, né senza
relazioni con essa, ma ne forma il complemento, la conferma, il termine, la
personificazione e l’interpretazione” (ibid.; cfr. Mt 5,17b).
Inoltre, “il Papa, che viene [dalla] rivelazione, non ha
giurisdizione sulla Natura” (Newman, ibid., p. 63). Don Giussani lo spiega
chiaramente ne La struttura dell’esperienza, pubblicato nel 1963 con
l’imprimatur dell’Arcidiocesi di Milano. Laddove l’esperienza cristiana si
presenta come “unità d’atto vitale risultante da un triplice fattore” (vale a
dire l’incontro con una realtà umana, la corretta percezione del significato di
tale incontro e la libera verifica di questa intuizione), l’autorità della Chiesa
fa parte del primo fattore, mentre il secondo è il cuore che giudica l’incontro
con quella realtà, includente la sua autorità. L’autorità, quindi, è ‘dentro’
l’esperienza cristiana; non può prevalere su di essa (Giussani, Il rischio
educativo, 2014, p. 130-132).
Newman prosegue discutendo un’obiezione. Alcuni ammettono
che, in effetti, il potere della Chiesa si basa sulla coscienza; ma sostengono
che, una volta che ci si sottomette all’autorità della Chiesa, il Papa “usi [di quel sentimento religioso]
destramente, formando sotto la sua egida un falso codice di morale per
sostenere la sua grandezza e tirannia; … così la Coscienza [diventa] sua
schiava, facendo il volere di lui, quasi per divina sanzione; in guisa che in
astratto ed in idea essa sia libera, ma nel fatto non mai capace di levare un
volo libero, indipendente da lui, più che gli uccelli che abbiano le ali
tagliate: dippiù, che, se essa potesse avere una volontà propria, ne seguirebbe
una collisione [indomabile]…: imperocché che cosa addiverrebbe della ‘assoluta
autorità del Papa’…, se anche la Coscienza privata avesse un’autorità
assoluta?” (Newman, Lettera al Duca di Norfolk, p. 64).
Il teologo inglese spiega poi che l’infallibilità del Papa
riguarda “proposizioni generali” e il “condannare certi particolari errori”,
mentre la coscienza non è un giudizio sulla dottrina o su verità speculative,
ma riconosce ciò che qui e ora dovrebbe essere fatto o evitato. La coscienza,
come il cuore in quanto tale, è una capacità non di definire in generale, ma di
riconoscere qualcosa di presente. Una “collisione” non potrebbe quindi mai
verificarsi in ambiti in cui la Chiesa gode di infallibilità, ma solo nelle
decisioni ecclesiastiche su questioni pratiche, ordini, legislazione e simili
(ibid., p. 65), anche se è fondamentale sottolineare che, anche in questo caso,
“a primo aspetto è [lo] stretto dovere [del cattolico]…, di credere che il Papa
abbia ragione, ed operare conformemente: egli deve vincere quella vile,
ingenerosa, egoista, volgare disposizione della sua natura, la quale al primo
sentire d’un comando si muove a fare opposizione al superiore che l’ha dato, si
domanda se questi non ha ecceduto ì suoi diritti, e si compiace moralmente e
praticamente di cominciare dallo scetticismo. Egli non deve avere nessuna idea
fissa di esercitare il diritto di pensare, parlare ed operare come gli pare e
piace, senza punto tener conto del vero e del falso, del giusto e
dell’ingiusto, del dovere di obbedienza, finché sia possibile, con quella
passione dell’animo che ne spinge a parlare conformemente ai propri capricci e
ad ostinarvisi. Se questa regola necessaria fosse osservata, sarebbero molto
rare le collisioni fra l’autorità del Papa e quella della Coscienza. Dall’altro
lato, nel fatto che la Coscienza è libera in fin dei conti nei casi
straordinari, noi troviamo la salvaguardia e la sicurezza, dove questa fosse
necessaria…, che nessun Papa potrà mai creare una falsa coscienza in pro dei
suoi fini particolari” (ibid., p. 66-67; corsivo aggiunto).
Va da sé che quanto Newman afferma sul rapporto tra
coscienza e l’autorità suprema del Papa vale a maggior ragione per le autorità
inferiori nella Chiesa. Suggerisco qui, senza poterlo approfondire ora, che ciò
che vale per la coscienza vale, e anzi, a fortiori, per il “cuore” nel senso
giussaniano (il complesso di evidenze ed esigenze originali con cui l’uomo “è
proiettato dentro il confronto con tutto ciò che esiste”; Giussani, Il senso
religioso, p. 8; cfr. ibid., p. 7-15).
La coscienza riguarda il bene e il male, ciò che si deve
fare o evitare. Newman scrisse sulla coscienza perché il dogma del 1870
riguardava l’infallibilità del Papa in materia di fede e morale, e anche
perché, nella filosofia del XIX secolo, la coscienza era (ancora) un fenomeno
umano fondamentale accettato (Lash, Introduction to An Essay in Aid of a
Grammar of Assent, by John Henry Newman, 1979, p. 13).
Egli voleva dimostrare che, nonostante la sua infallibilità,
il Papa non prevale sulla coscienza umana, ma la conferma, la completa, la
personifica e l’interpreta (Newman, Lettera al Duca di Norfolk, p. 63). Ora, la
coscienza morale fa parte del cuore (Giussani, Il senso religioso, p. 148-150).
Non solo siamo dotati di una coscienza morale, ma anche, e prima ancora, di un
senso del bello e del brutto, del vero e del falso, di ciò che libera e di ciò
che soffoca, ecc. Infatti, il cuore deve prima riconoscere la presenza di
questi valori affinché la coscienza possa dettare l’azione appropriata.
(…)
Continua su sussidiario.net